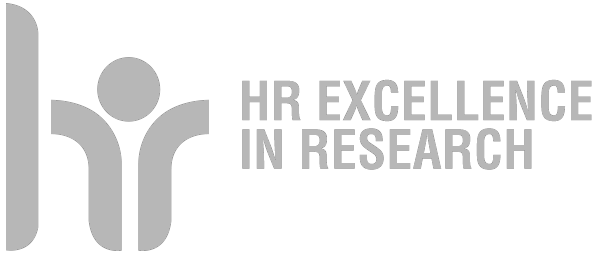Dai tubi di lava più giovani un nuovo sguardo sul mondo

Nel 2021 la spettacolare eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nel sud-ovest dell’Islanda, ha attratto centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il vulcano era rimasto dormiente da ben 800 anni e all’evento del 2021, durato circa sei mesi, hanno poi fatto seguito altre eruzioni e la penisola di Reykjanes sembra essere entrata in una fase nuova, con un risveglio magmatico che ha suscitato un forte interesse mediatico, ma che non è privo di incertezze e inquietudini sotto il profilo della sicurezza per gli abitanti della regione.
A cogliere sin da subito il potenziale scientifico dell’attività del vulcano Fagradalsfjall è stato il geologo e speleologo Francesco Sauro, ex alumni dell'università di Padova, che nel corso della sua carriera ha esplorato più di 60 miglia di grotte in tutto il mondo, occupandosi di esplorazioni geografiche e collaborando anche con la NASA e l’ESA nell’addestramento degli astronauti per le missioni esplorative nello spazio.
L’intuizione di Sauro, padovano classe 1984, presidente dell'associazione di Esplorazioni Geografiche La Venta è stata quella di non lasciarsi sfuggire l’opportunità di esplorare delle cavità particolarmente giovani, tubi di lava formatisi per effetto dei materiali depositati dall’eruzione del vulcano Fagradalsfjall.
Formazioni come queste grotte “sono costruite in un istante di tempo geologico", ha spiegato Sauro in un’intervista rilasciata alla rivista Smithsonian che dedica al tema la copertina del suo ultimo numero. È come avere a disposizione un laboratorio incredibile in cui è possibile non solo comprendere i processi di formazione delle grotte, ma anche osservare il processo di raffreddamento della lava e studiare l’evoluzione mineralogica ed ecologica di questi ambienti estremi.
Gli speleologi sapevano già che in circostanze come questa occorre fare di tutto per essere sul posto il prima possibile: il rischio, se si attende troppo, è che alcuni minerali rari “scompaiano” man mano che le temperature si abbassano. Era accaduto con i tubi di lava formatisi dopo l'eruzione dell'Etna in Italia nel 1993 e quell’esperienza è stata un insegnamento prezioso per gli scienziati.
Per questo motivo dopo una prima fase in cui il vulcano è stato studiato a distanza, attraverso immagini catturate da un aereo, da droni e avvalendosi di satelliti, Sauro e i suoi colleghi di La Venta si sono diretti in Islanda per esplorare le nuove grotte e raccogliere campioni di minerali presenti. Nel novembre del 2022 Sauro ha ottenuto un grant della National Geographic Society in supporto del progetto “Hraunrásir” per lo studio della mineralogia e della microbiologia di tubi lavici di recente formazione e in questo modo il team internazionale di esperti da lui guidato ha potuto condurre diverse spedizioni esplorative, la più complessa delle quali si è svolta nel giugno del 2023.

Per entrare nelle grotte gli scienziati hanno dovuto indossare delle speciali tute metallurgiche progettate per resistere alle alte temperature, respirando da serbatoi portatili pieni di aria compressa, perché l'aria all'interno era troppo calda e carica di gas tossici.
Lo studio di tubi lavici di recente formazione può rivelarsi essenziale per due linee di ricerca molto rilevanti. La prima è quella che si concentra sugli aspetti mineralogici allo scopo di comprendere la possibile genesi dei minerali secondari presenti nelle cavità. Preoccupati che alcuni minerali potessero cambiare o scomparire nel tempo, i ricercatori hanno portato sul sito un microscopio elettronico a scansione Phenom della Thermo Fisher per produrre immagini ad alta risoluzione dei campioni e avere così un aiuto per la loro identificazione.
Sui campioni sono poi state realizzate anche analisi più sofisticate, condotte presso i laboratori del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova sotto la guida del professor Fabrizio Nestola e con la collaborazione del ricercatore Riccardo Pozzobon e del professor Matteo Massironi.
Un minerale che attirato in modo particolare l’attenzione degli scienziati è la wulffite, un cristallo verde smeraldo la cui composizione comprende sodio e potassio insieme al solfato di rame. “È stato trovato solo una volta nella storia della mineralogia, in un sito vulcanico russo", osserva Fabrizio Nestola, Ordinario di Mineralogia a cui di recente sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti della Dana Medal e il titolo di Geochemistry Fellow 2024.
Nestola ha inoltre espresso la convinzione che alcuni minerali si riveleranno completamente nuovi per la scienza, rivelando potenzialmente processi ancora sconosciuti attraverso i quali avviene la mineralizzazione.
Un’altra linea di ricerca è quella che si dedica allo studio degli aspetti microbiologici con l’obiettivo di capire come queste grotte appena formate potrebbero iniziare a ospitare la vita: nei tubi di lava di più antica formazione è stata infatti scoperta un’enorme quantità di batteri e studiare gli organismi che li abitano potrebbe aiutare i ricercatori a perfezionare le loro idee su come la vita si è sviluppata sulla Terra, oltre a fornire indicazioni su come e dove cercare segni di vita, attuale o passata, su altri pianeti, come Marte.
Infine, un ulteriore motivo di interesse verso i tubi di lava deriva dal fatto che sono presenti anche nel sottosuolo lunare e marziano potrebbero rappresentare una risorsa per ospitare intere basi planetarie finalizzate all’esplorazione umana della Luna. ”Tra i vantaggi di un loro eventuale futuro utilizzo c’è il fatto che forniscono protezione dalla radiazione cosmica e solare, riparo dai micrometeoriti che impattano costantemente la superficie dei corpi planetari, e sono caratterizzati da un ambiente interno a temperatura controllata, non soggetta a variazioni tra notturne e diurne” osserva Riccardo Pozzobon, che da diversi anni studia la genesi e la morfometria di tubi lavici terrestri e i loro analoghi lunari e marziani.